|
BALLATE
POPOLARI
SCANDINAVE |
|
AGNETE OG HAVMANDEN |
|
AGNETE E L'UOMO
DEL
MARE |
|
|
|
|
|
La
ballata
 |
|
Agnete e l'uomo del mare (✍
1941) |
|
Johannes Bjerg (1886-1955)
Fontana monumentale. Åhrus (Danimarca) |
Agnete og Havmanden, «Agnete e
l'uomo del mare», nelle sue
numerose varianti, è una delle più famose e
popolari «ballate magiche» [trylleviser]
scandinave. Ne esistono versioni danesi,
norvegesi, svedesi
e tedesche. La più
popolare, qui riportata, è quella danese,
pubblicata nel 1853 da Svend Grundtvig nella
famosa raccolta Danmarks gamle Folkeviser,
«Antiche ballate popolari di Danimarca», dove è
classificata come DgF 38.
La trama è semplice. La giovane
Agnete sta
passeggiando su un ponte in riva al mare
quando un uomo esce dalle onde e le chiede di seguirlo nella sua dimora
sottomarina. La ragazza acconsente e vive per otto
anni con l'havmand,
l'«uomo del
mare», dandogli sette
figli. Un giorno, mentre sta cullando il più
piccolo, sente le campane che chiamano alla
messa e,
quasi svegliandosi da un incantesimo,
chiede al suo sposo di poter andare in chiesa.
L'havmand accetta ma le fa promettere
di ricordarsi di tornare dai suoi figli e le
impone una serie di divieti: non
sedersi al banco con la madre, non
inginocchiarsi quando il prete nominerà Dio,
non partecipare al banchetto domenicale.
Agnete promette e viene portata sulla
terraferma. Arrivata in chiesa, trasgredisce a tutti i divieti imposti dall'havmand.
Sua madre le chiede dove sia stata, e alla
risposta della fanciulla, le domanda che cosa
abbia ricevuto in cambio del suo
«onore»
dall'uomo del mare. Agnete elenca una serie
di oggetti preziosi, tali che nemmeno una
regina può vantarsi di possedere. Poi la madre
lascia la chiesa insieme alla figlia. In
quel mentre arriva
l'havmand e impone ad Agnete di tornare
con lui. Ma la fanciulla
non intende più vivere sotto il
mare, né si fa commuovere dal pianto dei
propri figli. L'havmand non può far altro che
ritornarsene nella sua dimora sottomarina
tra le risa di scherno di
Agnete.
|
|
Epoca
e luogo di redazione
La ballata Agnete og Havmand viene generalmente fatta
risalire a una redazione non anteriore al tardo XVIII secolo, e la critica
moderna ha sottolineato molti dettagli a sostegno di questi tesi. Il finale in
cui la fanciulla deride e scaccia l'uomo marino, testimonierebbe già una fase
piuttosto tarda, in cui l'havmand, perduto l'antico carattere soprannaturale,
è finito per assomigliare quasi a un «onesto borghese»
(D'Avino 1993). Anche l'estrema
semplicità del ritornello, un refrain che ripete, come in un eco,
l'ultima strofa del distico, dimostrerebbe inconfutabilmente la composizione
recente della ballata. Ad avallare ulteriormente questa tesi, Svend Grundtvig,
ha messo in evidenza l'affinità del genere ballatistico dell'havstagning
«rapimento in mare» con quello, più antico, del bergtagning
«rapimento nel monte», dove la protagonista
viene segregata in una montagna piuttosto che sul fondo al mare e,
nel finale, viene crudelmente punita per non aver ottemperato alle condizioni del suo
rapitore (Grundtvig 1853).
|
|
Le
varianti
Nella sua
introduzione alla ballata Agnete og Havmanden, Svend Grundtvig ne ipotizza
le origini meridionali, non
avendo trovato delle varianti simili in
Norvegia e Svezia ma, al contrario, avendole
rinvenute in
Germania e in Europa dell'Est. Grundtvig conta
infatti almeno cinque ballate in Germania
dello stesso tipo: Die Schöne Hannele «La bella Hannele»
(in due edizioni
diverse), Der Wasserman «L'uomo del
mare», Die Schöne Angnina «La bella Angnina» e
Die Schöne Agnete «La bella Agnete».
Tre di queste versioni ci dicono che
Hannele (Annerle,
Agnete) è figlia di un re
o di un proprietario terriero. Per lei viene
costruito un ponte sul mare, ma
appena la ragazza ci sale sopra, l'uomo del
mare la trascina giù con sé nella sua dimora
sottomarina. Le strofe successive sono molto
simili alla nostra ballata:
Dort unten war sie sieben Jahr,
und sieben Kinder sie ihm gebar.
Und da sie bei der Wiege stand,
da hört sie einen Glockenklang:
Ach Wassermann, ach Wassermann,
lass mich einmal zu Kirche gahn. |
Laggiù stette per sette anni,
e sette figli gli partorì.
E vicino alla culla stava,
quando sentì un suono di campane:
Ah, uomo del mare, ah, uomo del mare,
fammi andare da sola in chiesa. |
|
Die Schöne Hannele |
Il
Wassermann risponde: «Se ti lascio
andare in chiesa, non tornerai mai più».
Ma Hannele dice: «Perché non dovrei tornare
più? Chi baderà ai miei piccini?». Appena
arrivata al cimitero, saluta con riverenza
le foglie e l'erba verde; quando entra in
chiesa, saluta con riverenza i conti e i
nobili. Il padre gli fa posto nel banco e la
madre la fa sedere sopra un cuscino. Dopo la
funzione i genitori la portano a casa con loro e si
mettono a tavola, ma dopo il primo boccone
alla ragazza cade una mela in grembo. Allora chiede
alla madre di gettare la mela nel fuoco, ma
in quel momento arriva il
Wassermann e
dice: «Vuoi bruciarmi così? Chi baderà ai
nostri piccini?». «Dividiamoceli» propone
lei. «Tu ne prendi tre e io altrettanti». Ma l'uomo del mare risponde: «Allora
divideremo anche il settimo. Tu ti prendi
una gamba e io l'altra». A questo punto
Hannele esclama:
«Che mio figlio sia fatto a pezzi, piuttosto
che tornare a vivere nel mare!» [Und
eh ich mir lasse mein Kind zertheilen, viel
lieber will ich im Wasser bleiben!].
Nella quarta variante la protagonista è
Angnina, figlia del re d'Inghilterra.
L'incontro con l'uomo del mare (qui chiamato
der Nickelmann) avviene sempre allo
stesso modo, con la passeggiata sul ponte, e
anche qui, dopo aver sentito il
rintocco delle campane d'Inghilterra, la
fanciulla desidera tornare a casa. Ma
l'unica condizione per cui l'uomo marino la
lasci libera di andare in chiesa è che porti
con sé i suoi sette figli e che si lasci
assicurare alla caviglia una catena legata
direttamente con la dimora dell'essere
marino. Nel cimitero Angnina incontra il
padre e la madre che la riportano a casa e
la convincono a sciogliere il legaccio dal
piede. Non passa molto tempo che l'uomo del
mare tira a sé la catena, non trovando,
però, nessuno all'altro capo. La ballata
finisce con l'amara riflessione dell'essere
marino:
Ach liebe Königstochter mein,
wollst du nicht gerne bei mir sein?
So will ich dich nicht länger quälen,
und ich mich nicht zu Tode grämen. |
Ah, mia amata principessa,
non stavi volentieri con me?
Allora non ti rimpiangerò più,
né mi affliggerò fino alla morte |
|
Die Schöne Angnina |
Nell'ultima variante la fanciulla ha nome
Agnete. Qui l'uomo del mare prima la chiede
in sposa al re, suo padre. Dopo sette anni, la ragazza va in chiesa
e succede che «quando
arrivò sul sagrato della chiesa, gli stipi
della chiesa si piegarono»
[und als sie an
die Kirchthür kam, da neigte sich der
Kirchenschrank].
Allora Agnete esce dalla chiesa e
incontra il
Wassermann, il quale le chiede
se voglia seguirlo o perdere la vita. Agnete
risponde che preferisce morire
sulla terraferma piuttosto che seguirlo in
mare. Quindi l'essere marino sguaina la sua
spada e la decapita. Agnete
«cadde
lì sull'erba verde, e su ogni goccia di
sangue un angioletto si posava»
[sie sank dahin
in das grüne Gras, auf
jedem Tröpfen Blut ein Engelein sass].
 |
|
Agnete e l'uomo del mare |
|
Illustrazione di John Bauer (1882-1918) |
Grundtvig conclude asserendo che, laddove
la versione danese della ballata ha un
finale unitario nelle sue molteplici
varianti, le cinque versioni tedesche, a noi
pervenute, hanno tre finali diversi, di cui
il primo (cioè
quello in cui la ragazza preferisce rimane
sulla terraferma anche al costo di perdere i
suoi figli) deve essere il più antico, mentre la genuinità dell'ultimo
risulta dubbia (essendoci chiaramente un
risvolto edificante di matrice cristiana che
rimanda ai prodigi che accadono al martirio
di un santo) (Grundtvig
1853).
Tralasciando in questa sede le due
versioni est-europee (di cui una slovena),
Grundtvig richiama l'attenzione su un
episodio del
Kalevala
finlandese in cui la sorella di
Ilmarinen,
Annikki, sta in riva al mare intenta a
risciacquare dei vestiti. Quando
Väinamöinen,
nel suo viaggio verso
Pohjola alla ricerca
di una moglie, la vede, vira verso terra.
Annikki chiede svariate volte al vegliardo
il motivo del suo viaggio, ricevendo
altrettante risposte menzognere. Quando
Väinamöinen gli svela la sua vera mèta,
Annikki abbandona la spiaggia e corre da suo
fratello
Ilmarinen dicendogli che un altro
aspira alla mano della figlia della signora
di
Pohjola.
(Kalevala
[XVIII, -]). La situazione però si risolve qui.
Solo il nome della fanciulla è simile a
quella della versione finnica della ballata:
il resto è completamente diverso.
(Grundtvig 1853).
Al contrario, il runo finlandese
Il corteggiatore
marino [Merenkosiat] ci
ricorda la nostra ballata su Agnete:
Annika
(nome simile a quello della sorella di
Ilmarinen) stava seduta su un ponte e
piangeva, quando all'improvviso dal mare
salta fuori un uomo d'oro [Kultamies],
con la bocca dorata, con elmo e corazza
d'oro, con guanti, anelli e speroni d'oro
rutilante. L'essere chiede alla
fanciulla di seguirlo nel mare, ma lei rifiuta.
Annika
siede nuovamente sul ponte e uno
dopo l'altro sbucano dal mare un uomo
d'argento [Hopiamies], un uomo di
bronzo [Waskiemies] e un uomo di ferro
[Rautamies], con la stessa proposta,
ma tutti vengono respinti. Alla fine esce
dal mare un uomo di pane [Leipamies]
(il quale, come senso traslato potrebbe
essere avvicinato al tedesco Brodherr
«signore [che procura] il pane»,
il capo-famiglia che sostenta la casa), alla
cui proposta Annika risponde
finalmente di sì, marcando
una differenza fondamentale dalla nostra Agnete che invece accetta
subito di buon grado la
profferta dell'Havmand.
Bisogna qui sottolineare che
l'affermazione di Grundtvig riguardo la
mancanza di tale visa negli altri
paesi scandinavi, è figlia di un periodo in
cui la ricerca ballatistica era ancora ai
primordi. Al contrario, sia in Norvegia che
in Svezia sono state registrate delle
varianti molto simili al tipo presente nelle
Danmarks gamle Folkeviser, ma con
importanti cambiamenti nelle varianti più
antiche. Nella sua antologia, Massima Panza analizza tre varianti
registrate in Svezia ( , , ). Le due più
recenti ripropongo lo schema degli otto anni
di permanenza della protagonista nel fondo
del mare, il motivo del rintocco delle
campane, il ritorno sulla terraferma con
relativo incontro con la madre nella chiesa,
e il finale dove la protagonista si rifiuta
di tornare dai suoi figli e l'hafsman si strugge dal dolore. Al contrario, la
variante principale, evidentemente la più
antica, presenta un finale molto diverso.
Non solo l'uomo marino qui è detto
lejonman («uomo-leone», con riferimento al leone marino o otaria [infra]),
ma al solito schema segue un finale diverso: quando l'essere marino quando torna
per riprendersi la sposa, reagisce al suo
rifiuto colpendola fino a farla sanguinare;
quindi, caricatola sul dorso, la trascina
con sé in mare. (Panza
1999)
Tale finale, eccezionale nelle ballate del
tipo dell'havstagning
«rapimento in mare», è però quasi la
norma nelle ballate del tipo bergtagning
«rapimento nel monte», di cui conosciamo versioni
danesi, svedesi, norvegesi e feringe. Quando la fanciulla tenta la fuga, viene prontamente ricatturata dal
bergmann, il quale non
si astiene dal colpirla e, in alcuni casi,
addirittura dall'uccidere la ragazza,
riportando con sé il cadavere nella
montagna. Questi finali, in cui l'essere
soprannaturale non viene sconfitto ma, al contrario,
si dimostra
autoritario e potente, non si perde in lacrime al rifiuto
della ragazza ma se la riprende in modo
piuttosto brutale, dimostrano che
l'Agnetevisa scandinava è l'evoluzione di un tipo di ballata
più antico e diffuso, in cui il finale è
stato successivamente capovolto a favore della protagonista,
con una conclusione che segna la sconfitta dell'essere
soprannaturale
«diverso»
da noi.
|
|
Il
naturvæsen marino
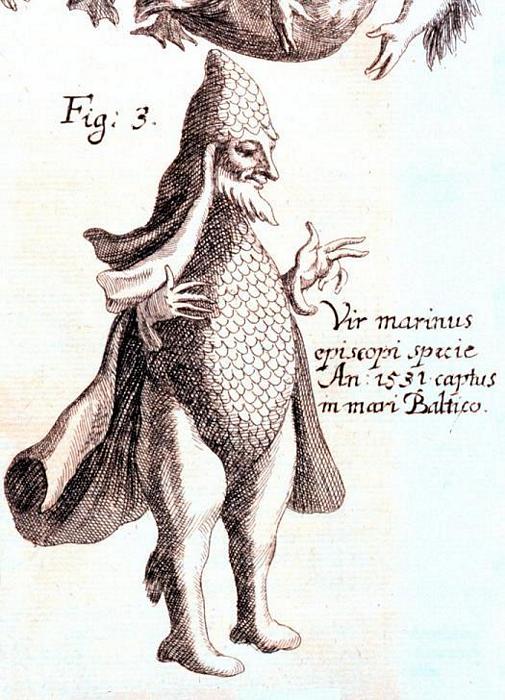 |
|
Uomo marino di specie Vescovo |
|
Immagine di un curioso essere antropomorfo marino, tratto
dallo Specula physico-mathematico-historica notabilium ac
mirabilium sciendorum di Johann Zahn (1631-1707),
pubblicato ad Augusta (Germania) nel 1696. Secondo la
didascalia, si tratterebbe di una specie di «vescovo marino» e
sarebbe stato catturato nel mar Baltico nel 1531. |
L'essere che seduce la fanciulla è definito,
in Agnete, «uomo
del mare» (danese havmand,
svedese hafsman, tedesco
Wassermann, inglese merman).
Ci si riferisce qui a una classe di esseri
del folklore scandinavo, di cui
le ballate conoscono tanto l'esemplare
maschile [havmand] quanto quello
femminile [havfrue]. Per
quanto la tarda letteratura indulga a raffigurare questi
havmænd
e queste havfruer con gambe pisciformi,
quando non addirittura con tutta la metà
inferiore del corpo di pesce, secondo
l'iconografia classica dei tritoni (un caso
emblematico è rappresentato dalla
lille havfrue,
la celeberrima
«sirenetta» di Hans Christian Andersen), nulla di
tutto questo traspare nelle antiche ballate,
dove l'uomo nel mare non ha alcuna
difficoltà a muoversi sulla terraferma. «Tritoni» e
«sirene» appartengono a un mondo mitico
lontano da quello scandinavo, e non
vanno confusi con gli
havmænd
e le havfruer.
Molti esseri
fantastici popolano i fiumi e i
mari della Scandinavia, tra cui il
marmendill (marmennill), il nykr (nøkk, näck), il fossegrim.
Nel vicino mondo slavo abbiamo il
vodjanoj, e anche il
Kalevala presenta molti esseri
che popolano le acque, non sempre
amichevoli, riuniti sotto la dizione
generica di Ahtolaiset «popolo di
Ahtola», essendo questo il regno di
Ahto, spirito-signore dell'elemento
liquido. Di homines
marini parla già Olaus Magnus, che li
descrive come «belvæ humana figura
apparentes» (Historia
de gentibus septentrionalibus [XXI:
De piscibus monstruosis]),
quindi esseri di aspetto umano ma natura animale. Diventa qui
significativa la versione svedese della ballata in cui l'hafsman
è definito lejonman
«uomo-leone»,
con riferimento in realtà a un genere di otaria (cfr. svedese moderno
sjölejon «leone di mare»). D'altra
parte, pare che l'aspetto originale di
queste creature non fosse ittiomorfo, bensì
focimorfo. In questo, forse, l'havmand
ha qualche relazione con i selkies,
gli uomini-foca delle isole Orcadi,
la cui tradizione si è in seguito attestata nel folklore
irlandese, scozzese e feringio.
Più
complesso interpretare la natura dell'havmand in relazione alla fanciulla
da lui sedotta. Sembrano esserci differenti
assi di opposizione, che non si escludono
necessariamente a vicenda. La principale
scuola antropologica vede in questa classe
di rapitori provenienti dal mare o dalla
montagna, a seconda delle ballate a cui si
fa riferimento, dei naturvæsen
«esseri del
mondo naturale». In questo caso l'aspetto
teriomorfico dell'havmand diventa
particolarmente significativo: se l'uomo del
mare è esponente di un mondo selvaggio e
primordiale, Agnete
rappresenta la
sfera culturale a cui appartengono gli esseri umani. In tal
caso la segregazione della fanciulla
nell'universo «naturale»
e il conseguente connubio teriogamico,
vengono a essere un riflesso di
rappresentazioni religioso-iniziatiche,
probabilmente derivate da antichi riti di
passaggio.
Alternativamente, il rapporto tra la
fanciulla e il naturvæsen può essere
visto come relazione tra un mondo
cristianizzato e i rimasugli dell'antico
sistema pagano. In questo caso appare
significativo il ritorno di
Agnete alla
chiesa, attraverso i cui riti la fanciulla
rientra nell'ordine sociale-religioso a cui
apparteneva, e può dunque spezzare
l'incantesimo che la legava all'uomo del
mare. Ma allo stesso tempo, non
dimentichiamo che l'havmand è anche
essere soprannaturale, appartenente a
una sfera di
transizione tra mondo fisico e metafisico.
Nel mito norreno,
Rán
trascinava con le sue reti sul fondo del mare
i marinai annegati e ad essi
serviva la birra nella sua dimora sottomarina.
Nel folklore scandinavo si
diceva che quegli annegati di
cui non si era trovato il corpo
fossero stati presi dall'havfrue o
dall'havmand, il quale dunque agiva come
custode del passaggio tra questo e l'altro
mondo (e qui ritorna il motivo del ponte sul
quale Agnete vede per la prima volta l'uomo
del mare [nota]). Col passar del tempo, questo
motivo può aver perduto le sue connotazioni
originali. In tal modo, nelle ballate,
questi esseri magici tendono a vivere un
matrimonio o un'unione de facto con
gli esseri umani, piuttosto che ucciderli e rapirli dopo
la morte.
|
|
Il
tema melusinico Analizzata
dal punto di vista strutturale, la ballata
di Agnete sembra doversi riconnettere a un
tema ben conosciuto agli studiosi di
fiabe e di folklore, quella che Laurence
Harf-Larcner ha definito «matrimonio
melusinico». Questo genere di vicenda ha per
argomento un'unione tra un essere umano
e una donna appartenente al mondo
soprannaturale, di cui la delicata leggenda
medievale di Mélusine
ne rappresenta, per così dire, il «modello»
(Harf-Lancner 1984).
Questa è la vicenda, nel racconto di Jean
d'Arras ( secolo).
 |
|
Mélusine |
|
Julius Hübner (1806-1882) |
Mentre Raimondin è a caccia nella
foresta di Colombiers, uccide per errore suo
zio. Sconvolto si rifugia in un bosco e,
presso una sorgente, si imbatte in tre
fanciulle. Una di queste, a nome di
Mélusine, gli
rivela di essere al corrente dell'incidente
occorsogli e di poterlo aiutare, offrendosi
di sposarlo, a patto che lui non cerchi mai
di vederla il sabato. Poiché la ragazza è
splendida, Raimondin è lieto di accettare. Il
matrimonio è assai felice: nascono numerosi
figli e la prosperità della coppia sembra
riversarsi anche sulle proprietà di
famiglia, i campi rendono sempre di più e
sorgono nuovi castelli. Tuttavia, ogni
sabato la sposa si rifugia nella torre,
sottraendosi per l'intera giornata alla
vista del marito. Il fratello di
Raimondin
sparge voci malevole sulle misteriose
assenze della giovane, tanto da indurre al
sospetto persino lo sposo, il quale,
sospettando qualche tradimento o infedeltà,
irruppe improvvisamente nelle stanze di
Mélusine e la
scoprì mentre si faceva il bagno,
trasformata in una donna-serpente. Violato
il divieto, Mélusine,
con il cuore spezzato e piena di vergogna,
sgusciò dall'acqua e volò via dalla finestra
della torre. Ricomparirà solo di tanto in
tanto come presagio di sciagure. I suoi
figli daranno tuttavia gran lustro alla
stirpe da lei fondata.
La morfologia di questa struttura
fiabesca è così riassumibile: (1) un essere
umano incontra una donna appartenente al
mondo soprannaturale; (2) il matrimonio tra
i due è condizionato da una serie di
interdizioni; (3) alla violazione di tale
interdizioni segue la rottura del legame
matrimoniale, e la donna torna al mondo a
cui appartiene. Il tema melusinico mette
dunque in scena la fusione tra due ambiti
apparentemente inconciliabili: il mondo
culturale-religioso a cui appartiene l'uomo
e il mondo soprannaturale di cui fa parte la
creatura feerica. L'incontro tra i due sposi
avviene sempre in
una regione di confine, che nel caso della
leggenda di Mélusine
è appunto una foresta, tópos che nella
letteratura medievale è deputato alle
epifanie di un soprannaturale di matrice celto-pagana. A permettere il matrimonio
tra due esseri appartenenti a ambiti tanto
diversi è l'osservanza delle interdizioni
imposte dalla donna all'uomo: una volta
violate, i due mondi non possono più
rimanere uniti e neppure l'amore
matrimoniale o materno è legame sufficiente
a trattenere la sposa a casa del marito.
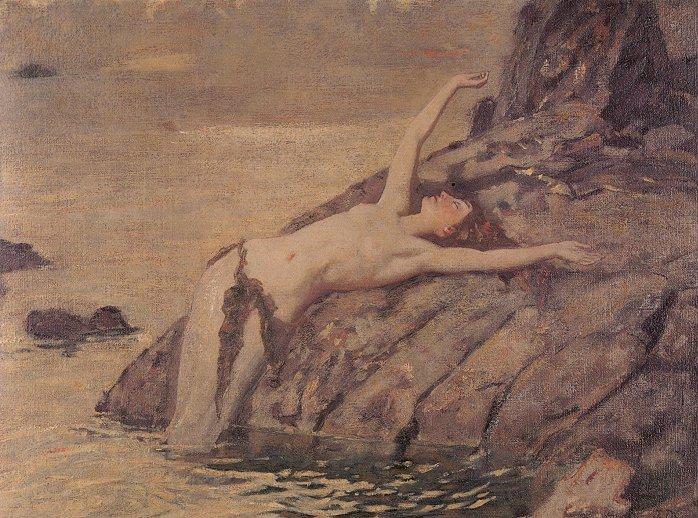 |
|
Selkie |
|
John Duncan (1866-1945). |
Il motivo è diffusissimo, ampiamente
attestato sia nella letteratura colta che
nel folklore, e non soltanto nei paesi
Europei. La leggenda celto-britannica delle
selkie ne è un caso emblematico.
Queste creature, conosciute come selch
(dall'anglosassone seolh «foca», cfr.
inglese seal) nelle isole Orcadi,
dove la leggenda si è probabilmente
originata, vivono nel mare in forma di pinnipedi, ma all'occorrenza possono
lasciare le lori pelli di foca tra gli
scogli e avventurarsi sulla terraferma in
forma umana, perlopiù di splendide fanciulle
(anche se sono attestati anche esemplari
maschili). È possibile per un uomo sposare
una selkie, impossessandosi appunto
della pelle abbandonata e impedendole di
tornare al mare. La selkie diviene
una sposa e diligente dell'uomo che l'ha
«conquistata», per quanto piuttosto
malinconica. Lo sposo deve però stare
attento che la selkie non ritrovi mai
la sua pelle di foca. E quando, come avviene
regolarmente, apre per caso una vecchia
cassapanca e lì dentro ritrova la sua antica
pelle, nulla può più trattenerla. Ella
abbandona lo sposo, i figli, i suoi stessi
abiti e scompare per sempre nel mare.
Abbiamo già sottolineato le affinità tra
l'havmand e il selkie, ma
detto questo,
Agnete og havmanden sembra
essere una versione speculare della leggenda
celto-britannica. Qui è infatti l'esponente
del mondo umano a muoversi nel mondo
soprannaturale, anche se poi è sempre il
membro femminile della coppia – secondo gli
schemi del matrimonio tradizionale – a
trasferirsi nella dimora dello sposo. Che
sia anche questo un tema melusinico è
testimoniato dal fatto che anche la ballata
scandinava presenta il motivo delle
interdizioni: quando la fanciulla sente
suonare le campane della chiesa e ha
nostalgia del suo mondo, l'havmand la
lascia andare a patto che gli prometta di
non fare una serie di cose: che non entri in
chiesa senza salutare, che non si sieda
accanto alla madre, che non s'inginocchi
quando il pastore invoca il nome
dell'Altissimo. Questi atti, riconducendo
Agnete nella sfera culturale-religiosa
umana, rompono infatti l'incantesimo che
tiene uniti i due ambiti normalmente
inconciliabili. La fanciulla ovviamente
disobbedisce e l'havmand perde ogni
suo potere su di lei. A quel punto, quando
l'uomo del mare va a riprendere la sua sposa
sulla terraferma, Agnete rifiuta di
obbedirgli, rimandandogli risposte
sprezzanti. Il ristabilimento della naturale
situazione di separazione tra mondo umano e
mondo soprannaturale è così netto e
definitivo, che neppure l'affetto di
Agnete
per il suo sposo e l'amore per i figli che
ha lasciato in mare possono indurla ad
abbandonare il suo mondo e tornare
dall'essere marino.
Sembra ovvio presumere che i tardi
cantanti della ballata, perdendo di vista il
significato dei vari elementi che
componevano la storia originale, abbiano
finito per dar loro sempre meno meno peso.
In tal modo il tema delle interdizioni,
conservato in alcune versioni dell'Agnetavisa,
è quasi del tutto perduto in altre (come
vedremo ora nelle due versioni qui
presentate). Analogamente, il tema del
rifiuto finale di Agnete, si è spostato su
una progressiva perdita di credibilità da
parte dell'essere marino. |
|
Contenuto e differenze
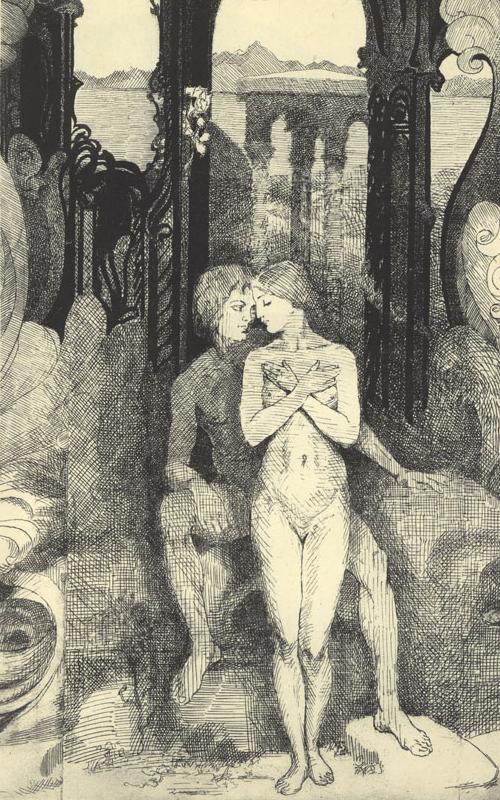 |
|
Agnete e l'uomo del mare (✍
1915) |
|
Illustrazione di Jens Lund, dal Drømmerens Bog. |
Le due varianti qui tradotte, tratte
dalla raccolta di Grundtvig, sono
contrassegnate come DgF 38A e DgF
38D. La seconda fu registrata nel
1845 dal pastore O.D. Lütken a Karleby, il
quale ci informa di averla «sentita
per molto tempo cantare dalle contadine di
Lumby».
Come vedremo nel testo, la variante D potrebbe essere diretta
derivazione del tipo A con cui condivide
molte strofe e ne aggiunge altre. Il tratto
fondamentale di D è l'incoerenza
nella numerologia «magica»,
la qual cosa forse sottolinea come questa
variante prenda le mosse da A
semplificandola ulteriormente (segnale di
una redazione ancora più tarda). È inoltre l'unica variante danese
nella quale la protagonista ha un nome diverso da
Agnete (per
quanto chiaramente derivato da questo,
Angenete). Seconda
differenza, si menziona un solo figlio, così
da eliminare gli otto delle altre varianti. Alla strofa [13] non viene menzionato il tempo
della permanenza della fanciulla presso
l'havmand, ma subito dopo, in una
strofa identica al tipo A, ci informa che è
stata dall'uomo del mare per otto anni e che
gli ha partorito sette figli. Evidentemente la
trasformazione della variante ha avuto
effetto solo sulle strofe precedenti,
lasciando questa inalterata, cosa non strana
nelle rielaborazioni seriori delle ballate, dove il cantante conosceva
il testo nella
sua interezza ma spesso finiva per
semplificarlo o, al perfetto contrario, aggiungere elementi che
avrebbero potuto destare maggiormente la
curiosità del pubblico. Forse in un'epoca
tarda il simbolismo magico dei numeri era
andato perduto e non si sentiva più il
bisogno di rappresentarlo, salvo poi
rimanere nella mente del
cantore.
Ugualmente, non sono presenti i divieti dell'uomo del mare,
che la ragazza violerà sistematicamente una
volta raggiunta la chiesa (ulteriore
segno di semplificazione), ma alla strofa
[18]
vediamo un'aggiunta, rispetto al tipo A,
degli oggetti che l'uomo del mare ha
regalato alla fanciulla per il suo
«onore». Interessante aggiunta ex novo
della variante D, sono
le ultime quattro strofe, in cui si dà anche
conto del significato del ritornello (cosa
non presente nella variante A), dato che in
alcune ballate più antiche il ritornello
poteva essere anche slegato dal contesto ballatistico
e ripetere solo un suono armonico. |
|
|
BALLATE
POPOLARI
SCANDINAVE |
|
AGNETE OG HAVMANDEN |
|
AGNETE E L'UOMO
DEL
MARE |
|
|
|
|
|
|
AGNETE OG HAVMANDEN Version A |
AGNETE E L'UOMO DEL MARE
Versione A |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Agnete hun ganger på Højelands Bro,
da kom der en Havmand fra Bunden op, |
Agnete va sul ponte
dell'alta terra:
lì giunse un uomo del mare dagli abissi. |
 |
|
|
– Hå hå hå! –
Da kom der en Havmand fra Bunden op. |
– Haa haa haa! –
Lì giunse un uomo del mare dagli abissi. |
|
|
2 |
»Og hør du, Agnete, hvad jeg vil sige dig:
Og vil du nu være Allerkæresten min?« |
«Ascolta, Agnete, cosa ho da dirti:
vorresti essere la mia amata?» |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Og vil du nu være Allerkæresten min? |
– Haa haa haa! –
Vorresti essere la mia amata? |
|
|
3
|
»O ja såmænd, det vil jeg så,
når du ta'r mig med på Havsens Bund.« |
«Oh, certo che vorrei esserlo,
quando mi porterai sul fondo del
mare.» |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Når du ta'r mig med på Havsens Bund. |
– Haa haa haa! –
Quando mi porterai sul fondo del mare. |
|
|
4 |
Han stopped hendes Øren, han stopped hendes Mund,
så førte han hende til Havsens Bund. |
Le turò l'orecchio, le tappò la bocca,
e la condusse sul fondo del mare. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Så førte han hende til Havsens Bund. |
– Haa haa haa! –
E la condusse sul fondo del mare. |
|
|
5
|
Der var de tilsammen i otte År,
syv Sønner hun da ved den Havmand får. |
Stettero insieme otto
anni,
sette figli diede all'uomo del
mare. |
 |
|
|
– Hå hå hå! –
Syv Sønner hun da ved den Havmand får. |
– Haa haa haa! –
Sette figli diede all'uomo del mare. |
|
|
6
|
Agnete hun sad ved Vuggen og sang,
da hørte hun de engelandske Klokkers Klang. |
Agnete sedeva vicino alla culla e cantava
poi sentì le campane d'Inghilterra suonare. |
 |
|
|
– Hå hå hå! –
Da hørte hun de engelandske Klokkers Klang. |
– Haa haa haa! –
Poi sentì le campane d'Inghilterra suonare. |
|
|
7
|
Agnete hun ganger sig for Havmand at stå:
»Og må jeg mig udi Kirken gå?« |
Agnete va dall'uomo del mare:
«Posso andare in chiesa?» |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Og må jeg mig udi Kirken gå? |
– Haa haa haa! –
Posso andare in chiesa? |
|
|
8
|
»O ja såmænd, det må du så,
når du kun kommer igen til Børnene små. |
«Oh, certo che ci puoi andare,
ma solo se ritorni dai tuoi figlioletti. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Når du kun kommer igen til Børnene små. |
– Haa haa haa! –
Ma solo se ritorni dai tuoi figlioletti. |
|
|
9 |
»Men når du kommer på Kirkegård,
så må du ej slå ud dit favre Guldhår. |
«Quando arrivi al cimitero
non devi scioglierti i capelli d'oro. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Så må du ej slå ud dit favre Guldhår. |
– Haa haa haa! –
Non devi scioglierti i capelli d'oro. |
|
|
10 |
»Og når du kommer på Kirkegulv,
så må du ej gå med din kær Moder i Stol. |
«E quando entri in chiesa,
non devi andare al banco dalla tua cara madre. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Så må du ej gå med din kær Moder i Stol. |
– Haa haa haa! –
Non devi andare al banco dalla tua cara madre. |
|
|
11 |
»Når Præsten nævner den høje,
da må du dig ikke nedbøje.« |
«Quando il prete nomina l'Altissimo,
non devi inchinarti.» |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Da må du dig ikke nedbøje. |
– Haa haa haa! –
Non devi inchinarti. |
|
|
12 |
Han stopped hendes Øren, han stopped hendes Mund,
så førte han hende på den engelandske Grund. |
Le turò l'orecchio, le tappò la bocca,
e la condusse sul suolo inglese. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Så førte han hende på den engelandske Grund. |
– Haa haa haa! –
E la condusse sul suolo inglese. |
|
|
13 |
Da hun kom på den Kirkegård,
da slog hun ud sit favre gule Hår. |
Quindi giunse al cimitero,
si sciolse i bei capelli d'oro. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Da slog hun ud sit favre gule Hår. |
– Haa haa haa! –
Si sciolse i bei capelli d'oro. |
|
|
14 |
Den Tid hun kom på Kirkegulv,
så gik hun med sin kær Moder i Stol |
Quando entrò in chiesa,
andò al banco dalla sua cara madre. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Så gik hun med sin kær Moder i Stol |
– Haa haa haa! –
Andò al banco dalla sua cara madre. |
|
|
15 |
Der Præsten nævned den høje,
hun monne sig dybt nedbøje. |
Il prete nominò l'Altissimo,
si inchinò profondamente. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Hun monne sig dybt nedbøje. |
– Haa haa haa! –
Si inchinò profondamente. |
|
|
16 |
»Og hør du, Agnete, hvad jeg vil sige dig:
og hvor har du været i otte År fra mig?« |
«Ascolta, Agnete, cosa ho da dirti:
dove sei stata per otto anni lontana da me?» |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Og hvor har du været i otte År fra mig? |
– Haa haa haa! –
Dove sei stata per otto anni lontana da me? |
|
|
17 |
»I Havet har jeg været i otte År,
syv Sønner har jeg ved den Havmand få't.« |
«Nel mare sono stata per otto anni,
sette figli ho dato all'uomo del
mare.» |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Syv Sønner har jeg ved den Havmand få't. |
– Haa haa haa! –
Sette figli ho dato all'uomo del mare. |
|
|
18 |
»Og hør du, Agnete, kær Datter min:
og hvad gav han dig for Æren din?« |
«Ascolta, Agnete, mia cara figlia:
cosa ti ha dato per il tuo onore?» |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Og hvad gav han dig for Æren din? |
– Haa haa haa! –
Cosa ti ha dato per il tuo onore? |
|
|
19 |
»Han gav mig det røde Guldbånd,
der findes ikke bedre om Dronningens Hånd. |
«Mi ha dato una fascetta d'oro rosso
miglior non si trova sulla mano di una regina |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Der findes ikke bedre om Dronningens Hånd. |
– Haa haa haa! –
Miglior non si trova sulla mano di una regina |
|
|
20 |
»Han gav mig et Par guldspændte Sko,
der findes ikke bedre på Dronningens Fod. |
«E mi ha dato un paio di scarpe dalle fibbie d'oro
miglior non si trovano al piede di una regina. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Der findes ikke bedre på Dronningens Fod. |
– Haa haa haa! –
Miglior non si trovano al piede di una regina. |
|
|
21 |
»Og han gav mig en Harpe af Guld,
at jeg skulde spille på, når jeg var sorrigfuld.« |
«E mi ha dato un'arpa d'oro,
che potessi suonare quand'ero triste.» |
|
|
|
– Hå hå hå! –
at jeg skulde spille på, når jeg var sorrigfuld. |
– Haa haa haa! –
Che potessi suonare quand'ero triste. |
|
|
22 |
Den Havmand han gjorde en Vej så bred,
fra Stranden op til Kirkegårdens Sten. |
L'uomo del mare si fece strada
dalla spiaggia fino alle lapidi del cimitero. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Fra Stranden op til Kirkegårdens Sten. |
– Haa haa haa! –
Dalla spiaggia fino alle lapidi del cimitero. |
|
|
23 |
Den Havmand han ind ad Kirkedøren tren,
og alle de små Billeder de vendte sig omkring. |
L'uomo del mare attraversò il sagrato
e tutte le icone si voltarono. |
 |
|
|
– Hå hå hå! –
Og alle de små Billeder de vendte sig omkring. |
– Haa haa haa! –
E tutte le icone si voltarono. |
|
|
24 |
»Hans Hår det var som det pureste Guld,
hans Øjne de vare så sorrigfuld.« |
I suoi capelli erano come l'oro più puro,
gli occhi davvero tristi. |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Hans Øjne de vare så sorrigfuld. |
– Haa haa haa! –
Gli occhi davvero tristi. |
|
|
25 |
»Og hør du, Agnete, hvad jeg siger dig:
og dine små Børn de længes efter dig.« |
«Ascolta, Agnete, cosa ho da dirti,
i tuoi figlioletti si struggono per
te.» |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Og dine små Børn de længes efter dig. |
– Haa haa haa! –
I tuoi figlioletti si struggono per te. |
|
|
26 |
»Lad længes, lad længes, så såre de vil,
slet aldrig så kommer jeg mere dertil.« |
«Lascia
che si struggano, lascia che si struggano
amaramente,
poiché non tornerò mai più da
loro.» |
|
|
– Hå hå hå! –
Slet aldrig så kommer jeg mere dertil. |
– Haa haa haa! –
Poiché non tornerò mai più da loro. |
|
|
27 |
»O tænk på de store og tænk på de små,
ja tænk på det lille, som i Vuggen lå.« |
«O
pensa al maggiore pensa al minore,
sì, pensa al piccolo, che giace in
culla.» |
|
|
|
– Hå hå hå! –
Ja tænk på det lille, som i Vuggen lå. |
– Haa haa haa! –
Sì, pensa al piccolo, che giace in culla. |
|
|
28 |
»Ret aldrig tænker jeg på de store eller små,
langt mindre på det lille, som i Vuggen lå.« |
«Non penserò più al
maggiore o al minore,
men che meno al piccolo, che giace in culla.» |
 |
|
|
– Hå hå hå! –
Langt mindre på det lille, som i Vuggen lå. |
– Haa haa haa! –
Men che meno al piccolo, che giace in culla. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AGNETE OG HAVMANDEN Version D |
AGNETE E L'UOMO DEL MARE Versione
D |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Angenete hun ganger på Høvelands
Bro,
der kommer den Havmand af Stranden
op |
Angenete passeggia sul pontile dell'alta terra,
dalla riva giunge l'uomo del mare. |
 |
|
|
– Ho ho ho! –
Der kommer den Havmand af Stranden op. |
– Ho ho ho! –
Dalla riva giunge l'uomo del mare. |
|
|
2 |
»Og hør du, Angenete, hvad jeg vil
sige dig:
og vil du følge til Havet med mig?« |
«Ascolta, Angenete, cosa ho da
dirti:
vuoi seguirmi nel mare?» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Og vil du følge til Havet med mig? |
– Ho ho ho! –
Vuoi seguirmi nel mare? |
|
|
3
|
»Ja, gjærne saa jeg til Havet
med ham,
hvis mine Forældre det ej spørge
skal.« |
«Sì, volentieri vorrei seguirti nel
mare,
se i miei genitori non dicono di
no.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Hvis mine Forældre det ej spørge skal. |
– Ho ho ho! –
Se i miei genitori non dicono di no. |
|
|
4 |
Han stopped hendes Øren, han lukte
hendes Mund,
så førte han hende til Havets Bund. |
Le turò l'orecchio, le tappò la
bocca,
e la condusse sul fondo del mare. |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Så førte han hende til Havets Bund. |
– Ho ho ho! –
E la condusse sul fondo del mare. |
|
|
5
|
Angenete hun sad ved Vuggen og sang,
da hørte hun Engelands Klokker de klang. |
Angenete sedeva vicino alla culla e
cantava,
poi sentì le campane d'Inghilterra
suonare. |
 |
|
|
– Ho ho ho! –
Da hørte hun Engelands Klokker de klang. |
– Ho ho ho! –
Poi sentì le campane d'Inghilterra suonare. |
|
|
6
|
Angenete hun sad ved Vuggen og græd:
»O, kunde jeg komme til min kjære Moder at stå!« |
Angenete sedeva vicino alla culla e
piangeva:
«Oh, se solo potessi andare dalla
mia cara madre!» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
O, kunde jeg komme til min kjære Moder at stå! |
– Ho ho ho! –
Oh, se solo potessi andare dalla mia cara madre! |
|
|
7
|
Angenete hun går for den Havmand at stå:
»Og må jeg mig ene til Kirken hengå?« |
Angenete va dall'uomo del mare:
«Posso andare da sola in chiesa?» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Og må jeg mig ene til Kirken hengå? |
– Ho ho ho! –
Posso andare da sola in chiesa? |
|
|
8
|
»Ja, vel må du ene til Kirken hengå,
når du vil komme igjen til dine Børn små.« |
«Sì, ben puoi andare in chiesa da sola,
ma solo se ritorni dal tuo figlioletto.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Når du vil komme igjen til dine Børn små. |
– Ho ho ho! –
Ma solo se ritorni dal tuo figlioletto. |
|
|
9 |
»Ja, visselig sandelig det jeg vil,
det skal du se og høre til.« |
«Sì, lo farò certamente,
vedrai e sentirai.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Det skal du se og høre til. |
– Ho ho ho! –
Vedrai e sentirai. |
|
|
10 |
Nu stopped han hendes Øren og lukte hendes Mund,
så førte han hende til den engelske Grund. |
Quindi le turò l'orecchio e le
tappò la bocca,
e la condusse sul suolo inglese. |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Så førte han hende til den engelske Grund. |
– Ho ho ho! –
E la condusse sul suolo inglese. |
|
|
11 |
Angenete hun ind ad Kirkedøren trådte,
så vendte alle de små Billeder sig omkring. |
Angenete varcò la porta della chiesa,
tutte le icone si voltarono. |
 |
|
|
– Ho ho ho! –
Så vendte alle de små Billeder sig omkring. |
– Ho ho ho! –
Tutte le icone si voltarono. |
|
|
12 |
Angenete hun til Alteret kom,
der stod hendes kjær Moder på den højre Hånd. |
Angenete giunse all'altare,
lì stava la sua cara madre alla destra. |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Der stod hendes kjær Moder på den højre Hånd. |
– Ho ho ho! –
Lì stava la sua cara madre alla destra. |
|
|
13 |
»Og hør du, Angenete, hvad jeg dig sige vil:
og hvor har du været så lang en Tid?« |
«Ascolta, Angenete, cosa ho da dirti:
dove sei stata per così tanto tempo?» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Og hvor har du været så lang en Tid? |
– Ho ho ho! –
Dove sei stata per così tanto tempo? |
|
|
14 |
»I Havet har jeg været i otte År,
syv Sønner jeg der med Havmanden får.« |
«Nel mare sono stata per otto anni,
sette figli ho dato all'uomo del mare.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Syv Sønner jeg der med Havmanden får. |
– Ho ho ho! –
Sette figli ho dato all'uomo del mare. |
|
|
15 |
»Og hør du, Angenete, hvad jeg dig sige vil:
og hvad gav han dig for Æren din?« |
«Ascolta, Angenete, cosa ho da
dirti:
cosa ti ha dato per il tuo onore?» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Og hvad gav han dig for Æren din? |
– Ho ho ho! –
Cosa ti ha dato per il tuo onore? |
|
|
16 |
»Han gav mig det røde Guldbånd,
der findes ikke bedre om Dronningens Hånd.» |
«Mi ha dato una fascetta d'oro rosso
miglior non si trova sulla mano di una regina.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Der findes ikke bedre om Dronningens Hånd. |
– Ho ho ho! –
Miglior non si trova sulla mano di una regina. |
|
|
17 |
»Og hør du, Angenete, hvad jeg siger dig:
hvad gav han dig mere for Æren din?« |
«Ascolta, Angenete, cosa ho da
dirti:
ti ha dato qualcos'altro per il tuo
onore?» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Hvad gav han dig mere for Æren din? |
– Ho ho ho! –
Ti ha dato qualcos'altro per il tuo onore? |
|
|
18 |
»Han gav mig en Guldkniv og Gaffel,
der lægges ikke bedre på Dronningens Taffel.« |
«Mi ha dato un coltello d'oro e una forchetta,
migliori non stanno sulla tavola di una regina.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Der lægges ikke bedre på Dronningens Taffel. |
– Ho ho ho! –
Migliori non stanno sulla tavola di una regina. |
|
|
19 |
»Og hør du, Angenete, hvad jeg siger mer:
hvad gav han dig mere for Æren din?« |
«Ascolta,
Angenete, cosa ho da dirti ancora:
ti ha dato qualcos'altro per il tuo
onore?» |
 |
|
|
– Ho ho ho! –
Hvad gav han dig mere for Æren din? |
– Ho ho ho! –
Ti ha dato qualcos'altro per il tuo onore? |
|
|
20 |
»Han gav mig et Par Guldspænder til Sko,
der findes ej bedre på Dronningens Fod.« |
«Mi ha dato un paio di scarpe dalle
fibbie d'oro
miglior non si trovano al piede di
una regina.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Der findes ej bedre på Dronningens Fod. |
– Ho ho ho! –
Miglior non si trovano al piede di una regina. |
|
|
21 |
»Og hør du, Angenete, hvad jeg siger dig mere:
og hvad gav han mere for Æren din?« |
«Ascolta, Angenete, cosa ho da dirti ancora:
e ti ha dato qualcos'altro per il tuo onore?» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Og hvad gav han dig mere for Æren din? |
– Ho ho ho! –
E ti ha dato qualcos'altro per il tuo onore? |
|
|
22 |
»Og han gav mig en Harpe af Guld,
at skulle spille på, når jeg var sorrigfuld.« |
«E mi ha dato un'arpa d'oro,
che potessi suonare quando ero
triste.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
At skulle spille på, når jeg var sorrigfuld. |
– Ho ho ho! –
Che potessi suonare quando ero triste. |
|
|
23 |
Hendes Moder vendte sig af Kirken ud,
Angenete tog Afsked med sorrigfuldt Mod. |
Sua madre si voltò per uscire dalla
chiesa,
Angenete prese congedo con animo
triste. |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Angenete tog Afsked med sorrigfuldt Mod. |
– Ho ho ho! –
Angenete prese congedo con animo triste. |
|
|
24 |
Den Havmand han gjorde en Vej så bred,
fra Stranden op til Kirkegårdens Sten. |
L'uomo del mare si fece strada,
dalla spiaggia fino alle lapidi del cimitero. |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Fra Stranden op til Kirkegårdens Sten. |
– Ho ho ho! –
Dalla spiaggia fino alle lapidi del cimitero. |
|
|
25 |
Den Havmand han ind ad Kirkedøren såe,
og alle de små Billeder dandsede sig omkring. |
L'uomo del mare guardò nella porta
della chiesa
e tutte le icone danzarono intorno. |
 |
|
|
– Ho ho ho! –
Og alle de små Billeder dandsede sig omkring. |
– Ho ho ho! –
E tutte le icone danzarono intorno.. |
|
|
26 |
Den Havmand han op til Alteret kom,
der stod Angenete alt ved hans højre Hånd. |
L'uomo del mare giunse all'altare,
lì stava Angenete alla sua destra. |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Der stod Angenete alt ved hans højre Hånd. |
– Ho ho ho! –
Lì stava Angenete alla sua destra. |
|
|
27 |
»Og hør du, Angenete, hvad jeg dig sige vil:
den små Børn længes nu såre efter dig.« |
«Ascolta, Angenete, cosa ho da
dirti,
il tuo figlioletto si strugge
amaramente per te.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Den små Børn længes nu såre efter dig. |
– Ho ho ho! –
Il tuo figlioletto si strugge amaramente per te.. |
|
|
28 |
»Lad længes, lad længes så såre som de vil,
i Havet har jeg været, der kommer jeg ej mer.« |
«Lascia che si strugga, lascia che si
strugga amaramente,
Nel mare sono stata, non ci
ritornerò più.» |
|
|
– Ho ho ho! –
I Havet har jeg været, der kommer jeg ej mer. |
– Ho ho ho! –
Nel mare sono stata, non ci ritornerò più. |
|
|
29 |
»Tænk nu på de store, tænk mere på de små,
men mest på det lille, som i Vuggen lå.« |
«Pensa al maggiore, pensa di più al
minore,
ma ancor di più al piccolo, che
giace in culla.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Men mest på det lille, som i Vuggen lå. |
– Ho ho ho! –
Ma ancor di più al piccolo, che giace in culla. |
|
|
30 |
»Hverken tænker jeg på de store eller små,
langt mindre på det lille, der i Vuggen lå.« |
«Non penserò più al maggiore o al minore,
ancor di meno al piccolo, che giace in culla.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Langt mindre på det lille, der i Vuggen lå. |
– Ho ho ho! –
Ancor di meno al piccolo, che giace in culla.» |
|
|
31 |
Den Havmand han vred sine Hænder derved:
»Det skulde du betænkt, da du havde mi der. |
L'uomo del mare si torceva le mani
a questo:
«Avresti dovuto pensarci, che tu
avevi me lì. |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Det skulde du betænkt, da du havde mi der. |
– Ho ho ho! –
Avresti dovuto pensarci, che tu avevi me lì. |
|
|
32 |
»Og vil du følge til Stranden med mig,
tolvtusind Tønder Guld dem giver jeg dig.« |
«Se mi seguirai alla spiaggia,
ti darò milleduecento barili
d'oro.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Tolvtusind Tønder Guld dem giver jeg dig. |
– Ho ho ho! –
Ti darò milleduecento barili d'oro. |
|
|
33 |
»Tolvtusind Tønder Guld dem haver jeg selv,
jeg giver dig Fanden, den kan dig følge med.« |
«Milleduecento barili d'oro li ho
già,
ti darò il diavolo, lui potrà
venire con te.» |
|
|
|
– Ho ho ho! –
Jeg giver dig Fanden, den kan dig følge med. |
– Ho ho ho! –
Ti darò il diavolo, lui potrà venire con te. |
|
|
34 |
Den Havmanden han rejste med et sorrigfuldt Mod,
Angenete hun stod for Stranden, og hjærtelig hun lo. |
L'uomo del mare se ne andò con
l'animo triste,
Angenete stava vicino alla riva e
rideva di cuore. |
 |
|
|
– Ho ho ho! –
Angenete hun stod for Stranden, og hjærtelig hun lo. |
– Ho ho ho! –
Angenete stava vicino alla riva e rideva di cuore. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE
1
A | 1
D — Il ponte è un
elemento topico di questo genere di ballate, quale tramite
tra il mondo umano e il mondo soprannaturale. Si veda, nel
mito scandinavo, la presenza del ponte
Bifröst a
collegare la terra e il cielo, dimora degli dèi. Anche nel folklore
e nelle fiabe, i ponti sono spesso luogo privilegiato di
accesso a un mondo «altro» e alle creature che lo popolano
(un esempio piuttosto noto, la fiaba scandinava dei tre
Capretti Furbetti, che incontrano un malvagio troll
proprio mentre scavalcano un ponte). Anche la riva del
mare è un tipico scenario della Grenzsituation, in
cui avviene l'incontro tra il rappresentante della cultura
umana e l'essere appartenente al mondo selvaggio e pagano.
In questo caso, Massimo Panza pensa alle Cantigas de
amigo del giullare galiziano Martím Codax (XIII sec.),
in cui «la
fascinazione della spiaggia [appare] come soglia d'un
attesa sospesa fra presentimento e desiderio»
(Panza 1999).
A D D
5
A — Secondo un ben preciso cliché, nelle
ballate la permanenza presso il naturvæsen
(sia esso uomo del mare o delle montagne) dura sempre
sette od otto anni. Al riguardo Massimo Panza al
riguardo pensa a un riferimento a qualche antico concetto
sulla sacralità di certi numeri. Ai sette anni di
prigionia fa riscontro il numero (otto) dei figli.
A
6
A | 5
D — L'Inghilterra è qui
introdotta come terra remota e lontana dall'esperienza dei
fruitori della ballata. Il motivo è diffuso anche in altri
testi. Ad esempio, il mostruoso uomo della montagna [bergman]
che, nella ballata svedese La
prigioniera del monte [Der Bergtagna]
rapisce la protagonista, è detto «re d'Inghilterra» [Konungen
i Engeland]
(Panza 1999). A D D
23
A |
11 D
— Al passaggio dell'Havmand, essere
proveniente da un mondo pagano, le immagini sacre voltano
il capo dall'altra parte, per evitare di guardarlo. Nella
versione D, questo
avviene anche quando passa la stessa Angenete, la quale,
proveniente dal mondo marino, non è evidentemente ancora
pronta per un ritorno definitivo all'ordine costituito. In
questa stessa versione, al passaggio dell'Havmand,
le immagini sacre sono dette
«danzargli intorno», forse per irridere la sua
futura sconfitta? A D D
28
A |
34 D
— Questa sarebbe la spia della seriosità di questa versione.
L'happy ending suggerirebbe una composizione
del tardo '700, laddove, come abbiamo detto
nell'introduzione, nelle ballate più antiche la ragazza
rimane per sempre nel regno incantato.
A D D
|
|
Bibliografia
- ANDERSON Poul, Merman's Children.
Putnam, USA 1979. → ID., I
figli del Tritone. Nord, Milano 1983. | ID.,
L'ultimo canto delle sirene. Delos, Milano 2007.
- ASBJØRNSEN Peter Christen ~ MOE Jørgen
Engebretsen, Norske folkeeventyr. Christiania [Oslo] 1841-1852.
- BRENTANO CLEMENS Arnim J., Des Kabe Wunderhorn,
alte Deutsche Lieder, I-III. Heidelberg, 1806-1809
- D'AVINO Maria Valeria, Antiche ballate danesi.
Salerno, Roma 1993.
- GRUNDTVID Svend Hersleb ~ OLRIK Axel, Danmarks
gamle Folkeviser, voll. I-XII. København 1853 [1976].
- HARF-LANCNER Laurence, Les fées au Moyen Âge.
Morgane et Melusine: La naissance des fées. Champion, Parigi 1984. ~
ID.:
Morgana e Melusina: La nascita delle fate nel
Medioevo. Einaudi, Torino 1989.
- HOFFMAN VON FALLERSLEBEN August Heinrich ~
RICHTER Ernst Heinrich Leopold, Schlesische Volkslieder.
Leipzig 1842.
-
ISNARDI Gianna Chiesa,
I miti nordici. Longanesi, Milano 1991.
-
LANDSTAD Magnus Brostrup, Norske folkeviser. Christiania
[Oslo] 1853.
- PANZA Massimo, I nomi magici nelle ballate
nordiche. In: Onomastica e Letteratura. Atti dell'Università di
Pisa, Viareggio 1998.
- PANZA, Massimo, Ballate magiche svedesi.
Luni, Milano/Trento 1999.- SCHRÖTER Hans Rudolph, Finnische Runen, Finnisch und Deutsch. Stuttgard/Tubingen 1834.
- SIMROCK Karl Joseph, Die Deutschen Volkslieder. Frankfurt 1851.
|
| BIBLIOGRAFIA ► |
|